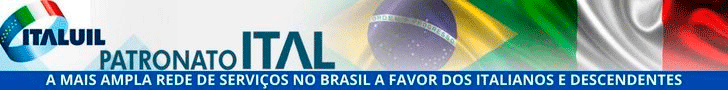Il digital divide
Di Prof. Alessio Lodes
La società dell’informazione, scaturita dai grandi cambiamenti tecnologici dell’ultimo decennio, è oggi ad un bivio. Per la prima volta nella storia, infatti, abbiamo a disposizione una tecnologia accessibile, con caratteristiche unificanti, potenzialmente ecumenica, facilmente distribuibile e, soprattutto, centrata sulla materia prima oggi più importante per la generazione di valore: l’informazione. Questa risorsa “tecnologica” non è stata inventata, né, nella sua forma di base, è vendibile; non ha le caratteristiche del prodotto inteso secondo i canoni dell’economia classica, né può essere ricondotta alle consuete dinamiche della domanda e dell’offerta; la rete, Internet, il web, le ICT (Information and Communication Technologies) possiedono oggi la forza di un paradigma diverso, alternativo, quasi rivoluzionario non solo rispetto alle tecnologie del passato, ma anche relativamente alla forma e all’organizzazione della nostra società così come la conosciamo. Oggi il termine “società dell’informazione”, non sta ad indicare il rinnovamento di una vecchia struttura di relazioni a cui, una tantum, si applica un sistema innovativo articolato sul progresso tecnologico, ma un vero e proprio ripensamento delle basi stesse della comunicazione che, d’altronde, sono quelle che regolano i contesti sociali stessi.
Dunque la società dell’informazione contiene in sé i germi di una trasformazione profonda e radicale del vivere sociale e, in questa prospettiva, va interpretata e considerata alla luce di una discontinuità storica e culturale. Nel 1501 erano stati stampati 2 milioni di incunaboli solo in Italia. Una cifra enorme, derivante dalla tumultuosa espansione delle stamperie supportata da una sempre più ampia richiesta da parte di un pubblico elitario di nuovi intellettuali. I caratteri mobili, del resto, si rifacevano ad una tecnologia relativamente banale, in gran parte già utilizzata dai cinesi i quali però non riuscirono a diffonderne l’uso. E, malgrado il manifesto vantaggio, il nuovo sistema non fu accettato ovunque: i paesi islamici si opposero per lungo tempo all’idea di un Corano a stampa e in India si dovette aspettare sino al 19mo secolo per avere la prima pressa. La tecnologia dunque, come ci mostra anche l’esempio della stampa, tende ad espandersi molto rapidamente, ma in modo essenzialmente concentrato ed elitario. I divari nella diffusione della stampa, nella lavorazione del cotone, nell’ industria metallurgica, nella diffusione della forza del vapore, nel sistema dei trasporti, nell’utilizzo dell’energia elettrica ecc. hanno creato il mondo di disuguaglianze così come lo abbiamo conosciuto. Dunque la velocità nella diffusione di una nuova tecnica/tecnologia, non deve illudere sulla sua ipotetica potenzialità di espansione ecumenica. Anzi, per certi versi la rapidità di espansione di una tecnologia potrebbe essere inversamente proporzionale al numero di persone che essa è in grado di raggiungere. Il bivio concettuale di fronte al quale ci troviamo analizzando le nuove tecnologie digitali, deve dunque tenere in considerazione anche questo possibile allargamento della sperequazione nell’accesso alla società dell’informazione. Laddove milioni di persone beneficiano dei vantaggi di una comunicazione in tempo reale, dalla quale è possibile ottenere informazioni altrimenti inarrivabili e determinare un’accelerazione dei processi tale da rendere possibile l’organizzazione ottimale della conoscenza, miliardi di persone sono ancora del tutto privi di una pur minima capacità di entrare nel contesto della società dell’informazione e subiscono le nuove tecnologie digitali né più né meno che come un ulteriore elemento di sperequazione tra il nord ricco e il sud povero. Il digital divide, ovvero la frattura che si va creando di giorno in giorno tra il microcosmo in grado di utilizzare e fruire dei benefici delle nuove tecnologie digitali e il macrocosmo che né è ancora lontano, costituisce così, in modo inevitabile, la cattiva coscienza della rivoluzione di Internet.
La Rete dell’informazione digitale oggi coinvolge meno del 10% della popolazione mondiale. Gli altri o stanno a guardare o non guardano neanche perché non sanno. Eppure molti ancora pensano che lo sviluppo di Internet e della società dell’informazione sia inarrestabile, che sia solo un problema di tempo e con calcoli statistici se ne possa prevedere la progressiva affermazione, visto che prima o poi tutti saranno connessi in un mirabolante digital dream che accomunerà i broker di Wall Street e i pastori del Sudan. Nulla di più sbagliato: se è vero che la diffusione di Internet cresce ancora, il suo tasso di crescita è oggi però irrisorio. La sensazione è che si sia raggiunta una soglia e che tale soglia sia oggi particolarmente ostica da superare. A partire da questa analisi, è abbastanza naturale individuare tre grandi fasi nello sviluppo della società digitale che, in qualche modo, la contraddistinguono rispetto ad altre epoche di trasformazione tecnologica. La prima fase è stata quella dell’incendio nella prateria, rapido, incontrollabile, impetuoso ma, soprattutto, vorace; in questa fase l’élite economica e culturale del mondo sviluppato, quel 10% di cui si parlava poco sopra anzi, è stata raggiunta in modo istantaneo dalla buona novella e ha rafforzato il suo status. Nel 1992 quasi nessuno aveva Internet, nel 1998 l’élite del mondo era stata raggiunta quasi totalmente. La seconda fase è quella che stiamo vivendo attualmente, e che ci mette di fronte alla disillusione e al disinteresse; è la fase di una crescita più lenta e più difficile, ancora riservata ai pochi; ed è forse proprio questa la fase giusta per approfondire la riflessione sui temi del divario che va allargandosi tra i parlanti e gli afasici della società dell’informazione.
A ogni ciclo tecnologico, ci spiega Armand Mattelart, si rinnova l’illusione millenaristica della concordia universale portata dalla tecnologia; a questo seguono fenomeni di amnesia sociale riguarda alle tecnologie precedenti che comportano un’inevitabile rafforzamento di quelle élite che ne sono temporaneamente depositaria. La rivoluzione internettiana non fa eccezione: oggi sembra quasi di essere reduci da una sbornia senza accorgerci che la festa a cui abbiamo partecipato ci ha cambiato per sempre. Dunque abbiamo bisogno di uno stadio ulteriore. La terza fase è quella che abbiamo l’ambizione di costruire. E’ qui che si gioca la sfida per il futuro: l’obiettivo è quello di assicurare una crescita omogenea e di immaginare un progetto credibile per il mondo che verrà, per il nord e per il sud, per i ricchi e per i poveri, per i parlanti e per gli attuali afasici. Per parafrasare i rivoluzionari russi, potremmo chiederci se il modo migliore per raggiungere questo scopo sia la rivoluzione tecnologica permanente o Internet per una sola élite. Similmente ad altre profonde trasformazioni tecnologiche (la rivoluzione industriale, le ferrovie, l’elettricità….) quella della società digitale si trova ad attraversare la sua crisi di crescita. Similmente ad altre rivoluzioni tecnologiche questa criticità rischia di determinare un “gradino” nello sviluppo omogeneo globale e di lasciare ancora più indietro quei paesi e quelle fasce sociali che hanno già significative situazioni di svantaggio. Come in passato, e forse in modo ancor più accentuato, si corre il rischio di trascurare, per scarsa consapevolezza storica e per la difficoltà a gestire le discontinuità culturali, una grande opportunità di sviluppo governato e omogeneo. Per questo riteniamo che l’unica risposta possibile sia quella di cercare con tutti i mezzi possibili che la crescita non si arresti e che questa soglia venga oltrepassata. Insomma, per la terza fase della new economy, noi scegliamo quella ipotesi che ci può condurre ad una vera trasformazione globale, quella delle rivoluzione digitale permanente che coinvolga tutto il pianeta e non lasci indietro nessuno. E, si badi bene, non si tratta solo di una banale pulsione egualitaria (benché già questo ne giustificherebbe il senso), ma di una componente fondamentale per l’affermazione di una società dell’informazione prospera ed equilibrata. Lasciando il controllo e l’accesso alle nuove tecnologie digitali esclusivamente ad un’élite, non si avrà possibilità alcuna di generare quel valore aggiunto globale che potrebbe derivare dall’individuare modelli di sviluppo alternativi. E quindi anche noi che di questa élite facciamo parte, saremmo alla fine più poveri.
L’11 settembre è crollata definitivamente una grande illusione di progresso. La sofferenza collettiva officiata dai mille canali televisivi che in diretta ci hanno mostrato l’agonia del cuore dell’occidente ricco, ha chiuso un’epoca e ne ha aperto un’altra. L’epoca che si è chiusa è quella del grande ottimismo tecnologico, della crescita senza limiti, della ricchezza che si propaga come un vangelo, della possibilità di creare un mondo nuovo basato sulla virtualità; l’epoca che si è aperta è quella del controllo, e dell’assenza di comunicazione: tutto deve esser riportato alla concretezza del reale, al controllo fisico, alla pesantezza. Il verbo millenaristico della new economy, già in crisi per la congiuntura negativa dell’economia internazionale, ha avuto il suo colpo di grazia definitivo. Di rado una discontinuità così evidente ha segnato le epoche della nostra storia recente; di rado siamo stati tanto incapaci di poter prevedere il futuro. Il 10 Marzo del 2000 è la data in cui il Nasdaq toccò il suo livello più alto; la combinazione tra sviluppo tecnologico e crescita finanziaria aveva creato una sorta di età dell’oro per cui la ricchezza sembrava ormai la condizione normale. In questo periodo furono comunque gettati i semi di una cultura diversa, fondata sulla cooperazione e la comunicazione, informale, dotata di una forte spinta creativa che mescolava l’individualismo del self-made-man o del programmatore che lavora solo durante il turno di notte con la nuova apertura partecipativa degli hacker e dei profeti dell’open source. Per la prima volta nella storia la comunicazione e l’informazione non sono stati solo i veicoli della rivoluzione tecnologica, ma ne sono stati gli oggetti. La struttura relazionale è quella, come afferma Manuel Castells, di una società informazionale, in cui l’informazione è il luogo e il momento topico dell’innovazione. Oggi tutto questo non può essere stato seppellito sotto le rovine del World Trade Center. Già, ma allora che fine ha fatto?
L’11 Settembre ha segnato la nemesi della guerra e la sconfitta, che ci auguriamo provvisoria, della cultura dell’incontro . Una sorta di spartiacque simbolico che ha riportato le menti alla pesantezza degli anni della guerra fredda, delle contrapposizioni, degli scontri di civiltà, contro la leggerezza solare della new economy, dell’aria salmastra dei parchi di Silicon Valley, di una visione del mondo basata sulla libertà della crescita virtuale che avrebbe costituito l’antidoto ai fantasmi della incomunicabilità. Questo non arresterà la legge di Moore4 , ma al tempo stesso costituirà una cesura profonda da cui, però, è fondamentale non lasciarsi sopraffare. In molti sensi, ciò costituisce lo sfondo di quella seconda fase dello sviluppo della rete che dobbiamo sforzarci di superare.
Testi consultati:
- Zocchi, P. Il male oscuro di internet. Milano: Guerrini. 2010;
- Zocchi, P. La cultura della Rete, segno di discontinuità nella logica dell’economia di guerra, in “Europa”. Milano: Mondadori, 2003;
Prof. Alessio Lodes
Pordenone (Italia)
email: prof_biblio_lodesal@yahoo.com